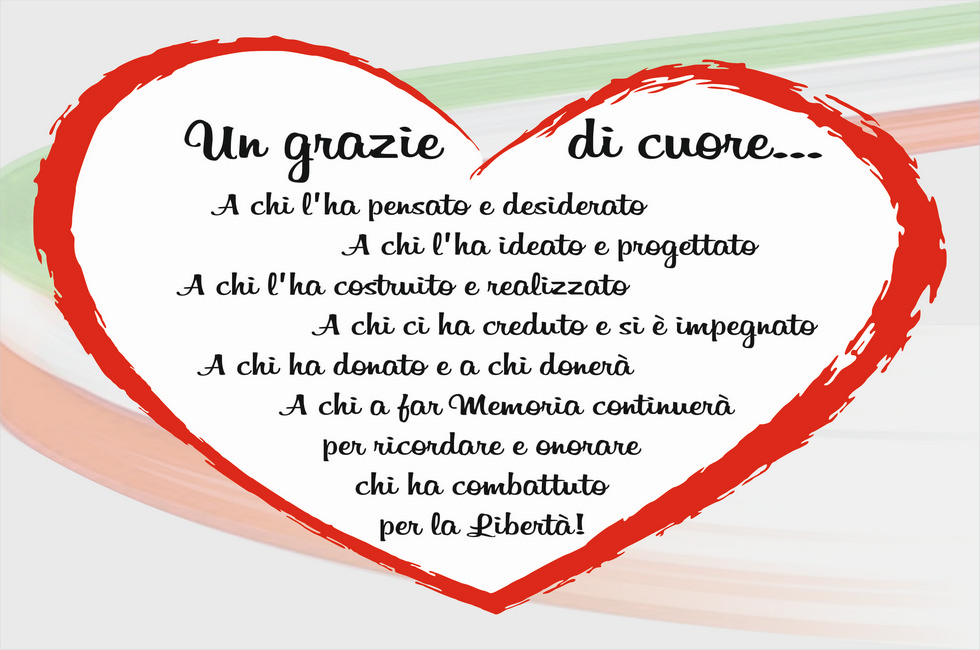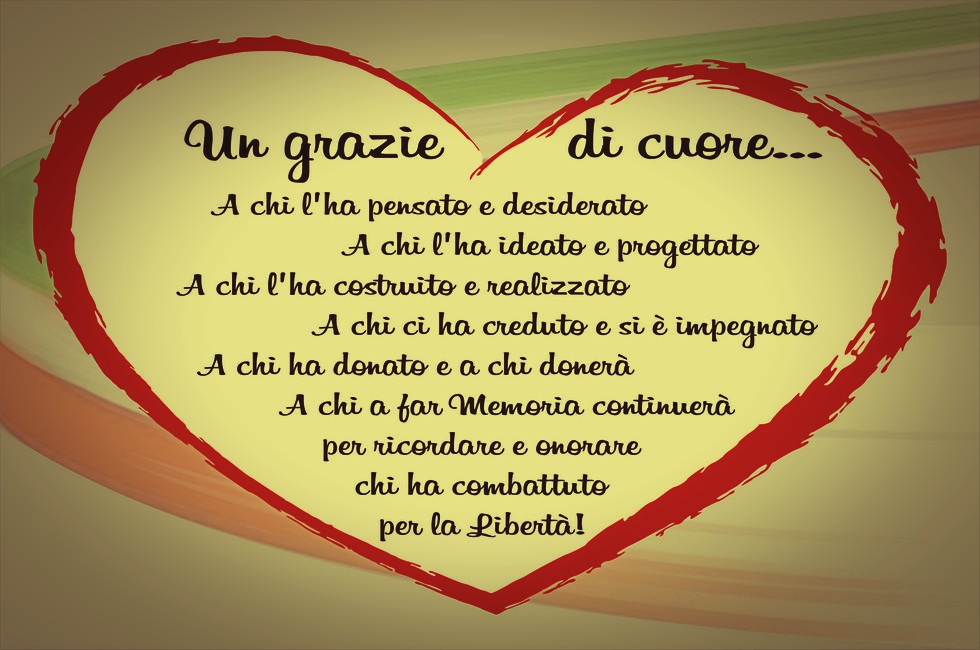La distruzione di gran parte dell’abitato di Cevo è preceduta, nella
primavera del 1944, da rastrellamenti in grande stile. Il 19 aprile un’azione
combinata di reparti tedeschi e repubblichini chiude la zona in una tenaglia per sradicare la presenza garibaldina: grazie al tam tam informativo e alla conoscenza ravvicinata del territorio, i partigiani possono sganciarsi senza perdite.
Alcuni rastrellamenti durano più giorni e costano l’arresto a diversi civili,
sospettati di favoreggiamento dei ribelli.
Il segnale di un’inedita attenzione dell’apparato repressivo nazifascista
alla Valsaviore si ha, alla metà del maggio 1944, con l’arrivo in zona del
Reparto Polizia Speciale, meglio noto come «Banda Marta». Si tratta di
una formazione apparentemente irregolare e perfettamente armata, i cui
componenti sostengono di essere partigiani ansiosi di collegarsi con i loro
compagni. Questa forma raffinata e provocatoria di antiguerriglia, diretta
dai tedeschi, alterna i furti alle violenze: vengono rubati muli e vitelli,
svaligiati i negozi, saccheggiate le abitazioni. I derubati sporgono denunzia
alla caserma della Guardia Nazionale Repubblicana, dove si trascrive in un
rapporto la fitta segnalazione di reati, evitando però qualsiasi intervento.
Nel Notiziario sulle «operazioni contro i ribelli», il Comando provinciale
della GNR svela con qualche imbarazzo la reale natura della formazione:
«La banda segnalata in Valsaviore e che deve essersi accampata in località
Fabrezza è – come già sospettavano i valligiani – non composta da elementi
sbandati o ribelli, ma da persone ingaggiate dal Comando germanico per
combattere i banditi con le loro stesse armi e con i loro sistemi. Sembra
però che le rapine, succedendosi con un crescendo eccessivo e consumate
quasi tutte in danno di povera gente, mentre hanno inasprito gli animi
hanno anche messo sull’avviso i ribelli».
Nell’intento di agganciare i ribelli, all’alba del 19 maggio gli uomini della
Banda Marta – in rastrellamento concentrico da Prato Lungo (Prà Long),
da Denseuer e da Saviore – costringono alcuni contadini a guidarli sino ai
fienili di Musna, tradizionale rifugio di renitenti e partigiani.
Uno dei malcapitati sequestrati con la forza dai banditi neri – Giovanni
Boldini – viene talmente percosso da ammalarsi e morire poco tempo
dopo. Sulla spianata alpina, qui visibile in una fotografia d’epoca, incombe
la tragedia.
Giunti all’altipiano di Musna i primi militi irrompono in una baita e
sorprendono tre renitenti alla leva; ne segue una convulsa zuffa, nella quale
un fascista resta ferito. Il rumore della sparatoria fa accorrere rinforzi della
Marta; presi da inconsulta brama vendicativa, i fascisti truccati da partigiani
uccidono due vecchi agricoltori, i coniugi Giovanni e Maria Monella con
la figlia Maddalena (sua sorella Tina sfugge alla morte nascondendosi
nella stalla). Gli sgherri allineano sulla radura i contadini scovati nei fienili
e pretendono di sapere dove siano nascosti i garibaldini; non ricevendo
indicazioni utili, fucilano lo scalpellino quarantunenne Francesco Belotti.
L’episodio viene così registrato nei Notiziari della GNR: «Una quindicina
dei suoi camerati [di un ferito della controbanda] hanno tentato un’azione
contro la banda dei ribelli. Sennonché, portatisi nella baita di Giovanni
Daniele Monella, per motivi non ancora ben precisati, hanno ucciso con
raffiche di fucili mitragliatore il predetto Monella, la moglie e la figlia,
di 29 anni. Poi, raccolte alcune persone, con altra raffica di pistola
mitragliatrice, ne hanno uccisa una – certo Francesco Belotti, scalpellino
– che, a domanda, aveva risposto per primo di non avere notato ribelli
nelle vicinanze. Dopo di ciò i suddetti elementi hanno imposti a tre civili
di scavare una fossa per seppellire i quattro cadaveri».
Tra i pochi coraggiosi a onorare le vittime vi è il calzolaio socialista
Agostino Comincioli (nato a Cevo nel 1912), Egli – che ha preparato
tante paia di scarpe per i partigiani e che ha la sorella Enrichetta deportata
in un Lager – costruisce quattro croci di ferro e le colloca in un grande
albero (dove si vedono ancora oggi, in parte ingoiate dal tronco: si veda la
fotografia della pagina successiva).
La banda fascista al servizio dei tedeschi uccide altre due persone, a Zazza,
nella marcia di trasferimento dalla Valsaviore alla Val Malga. Il curato
don Giovanbattista Picelli, sospettato di favoreggiamento dei ribelli (cfr.
p. 000), e il renitente Giuseppe Gelmi: catturato con il proposito di usarlo
come guida verso le postazioni garibaldine, fugge, ma dopo un paio di
giorni viene avvistato e ucciso dai falsi partigiani.
In parallelo con l’incursione della controbanda, il 22 maggio i tedeschi
sferrano un durissimo rastrellamento, rincalzati da duecento militi fascisti
che, saliti dalla Val Malga, vogliono debellare il gruppo di Bigio per poi
passare in Valsaviore e investire la roccaforte della 54a Brigata. Attraverso
vie di fuga ardite, i partigiani riescono a defilarsi, a costo di gravi rischi e
fatiche estenuanti.
Dopo il sostanziale fallimento dell’incursione della Banda Marta e il buco
nell’acqua del bando Mussolini per la presentazione dei disertori entro la
mezzanotte del 25 maggio (con promessa di perdono), inizia un periodo
di relativa tranquillità, utilizzato dai partigiani per rafforzarsi sul piano
logistico-organizzativo.
A questo punto, di fatto, la Valsaviore è una zona libera, autogestita dai
garibaldini.
Da “Il Museo della Resistenza di Valsaviore - Guida alla storia e alla documentazione”
di Mimmo Franzinelli